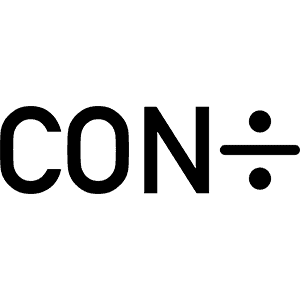Cristiano, cosa vuol dire essere l’Art Director di Condiviso?
Significa innanzitutto aver contribuito alla costruzione di un progetto a partire dalla sua nascita, con tutta la libertà che questo ti lascia e con tutti i rischi ai quali l’eccessiva libertà ti espone: la proverbiale paura del foglio bianco. Si è trattato di costruire l’immagine di chi, come Condiviso, la creazione dell’immagine la vende, e la storia del ciabattino con le scarpe rotte non ha mai funzionato veramente, infatti i ciabattini non esistono più.
Dunque, dividerei in due fasi il lavoro fatto: una prima parte che riguarda la creazione del brand, costituita inizialmente da una fase di studio e di ricerca di key history, fase nel quale un Art Director ha la responsabilità di trasformare un progetto di marketing e comunicazione in qualcosa di visibile sempre e ovunque, in principio attraverso una ricerca dei competitor, poi con la realizzazione di alcune visual identity di prova e, infine, con un lavoro di verifica della correttezza dell’immagine creata. Naming, logo, colori, font e grafica devono essere chiari, leggibili e riconoscibili in ogni strumento di comunicazione, dal social network al catalogo, dal sito web all’advertising. La seconda parte consiste in una sorta di lavoro militaresco: si deve tenere la barra dritta e seguire ostinatamente il progetto d’immagine costruito, altrimenti le cose non funzionano. Ovviamente il tempo cambia le cose e di conseguenza ci sono adeguamenti o scelte da fare, ma se un progetto è buono significa che è stato pensato previdentemente e alcuni passaggi programmati con largo anticipo. Una visual identity ben pensata perdura nel tempo almeno 5 o 10 anni, poi, forse, si può pensare ad un restyling.
Questo è il biglietto da visita di Condiviso: il lavoro che facciamo per noi lo facciamo anche per i nostri clienti, con le stesse regole e la stessa passione.
Puoi spiegare cos’è la visual identity e perché è così importante per un’impresa?
No, spiegarlo sarebbe tautologico. Si possono però fare degli esempi: se nel mio curriculum scrivessi che sono meccanico, clown, art director, istruttore di acquagym e promotore finanziario, tranne in rari e fortunati casi, metterei a disagio un responsabile delle risorse umane che vuole velocemente capire se sono il candidato che fa per lui e, a proposito di tautologia, è proprio la frase “tranne in rari casi” la più significativa, perché non si può pensare alla fortuna.
L’immagine di un’azienda permette in pochi secondi di dire ad una moltitudine la cosa più importante. È necessario programmare una comunicazione efficace, semplice, diretta e sempre riconoscibile che rimanga in testa: ogni volta che un’azienda si mostra, ogni volta che parla e che comunica deve mostrare la stessa immagine, altrimenti la perdiamo. Non mi piacciono i paragoni calcistici ma è come se una squadra entrasse in campo e ogni giocatore indossasse una maglietta di colore diverso. Non discuto sul fatto che potrebbe essere esteticamente molto bello, ma oggettivamente non si potrebbe giocare.
L’identità visiva, in buona sostanza, è questo: quell’insieme di forme e colori che comunicano chi sei prima ancora di incontrarti. Le persone che conosciamo le identifichiamo da lontano, per il loro incedere, per la loro struttura o per il modo di vestire, e le riconosciamo quando ci arrivano alle spalle perché ricordiamo il loro passo o il loro profumo. Queste sono cose naturali ma quando si comunica bisogna ricrearle artificialmente e rafforzale quanto più possibile, ne va dell’efficacia e della capacita della propria attività, qualunque essa sia: un prodotto o un servizio.
Quando un cliente ti chiede un nuovo logo per il suo brand, da dove prendi l’ispirazione? Come nasce l’idea per la sua realizzazione?
Dunque, è importante intendersi su una cosa: un creativo non è un artista e non è un esteta. La questione non è fare una cosa bella o brutta, ma bensì fare la cosa giusta. Il packaging di un prodotto, ad esempio, dice quasi tutto del suo posizionamento. Se la confezione è bella significa che è costoso, se è brutta significa che è economico (banalizzando). Di conseguenza, se il logo di un’impresa deve esprimere il posizionamento del proprio prodotto o della propria attività, non deve per forza essere bello, ma deve essere coerente, altrimenti esprime falsità sul proprio conto creando un problema etico ancor prima di un errore commerciale.
In ogni caso applico una prassi molto metodica. La prima cosa da fare è guardarsi attorno, che nel mio lavoro significa fare un’attività di ricerca su realtà simili, per cercare fonti d’ispirazione da cui “copiare”. Ovviamente non si replica mai nulla, ma l’ispirazione si cerca e si trova tra le cose intorno a noi, non seduti al buio circondati dal nulla. Significa andare in libreria, cercare su portali di riferimento (Pinterest ad esempio) per poi fare un lavoro con i propri colleghi, in modo da osservare il progetto da angolazioni diverse. Ogni lavoro al mondo è un lavoro di squadra che prende il via da ciò che già esiste. Il passo successivo prevede il lavoro creativo, fase in cui la sensibilità personale e le proprie capacità interpretative diventano soggettive. Infatti ogni professionista ha poi il suo carattere riconoscibile. Personalmente preferisco la costruzione di loghi le cui forme e i cui colori abbiano sempre una funzione e rispondano sempre alla domanda: “ma perché è fatto così?” Credo che questa sia la condizione per fare un lavoro giusto che rispetti la natura del cliente, il suo passato, i suoi obiettivi e che sia in grado di esprimere il valore da comunicare.
Ci è capitato di disegnare loghi per molte categorie diverse: culturali e sociali, alimentari, legate al mondo del lusso o dei servizi. In ognuno di questi casi il progetto è profondamente diverso ma il metodo è lo stesso. Ci sono poi un po’ di regole che, in quanto tali, sono fatte per essere disattese, ma che comunque dettano il gioco. Ad esempio i colori e le forme: l’azzurro è sinonimo di professionalità e competenza, il rosso è allarme, il verde è tranquillità, le forme arrotondate avvolgono, quelle spigolose sono dinamiche. Insomma, basta guardare i segnali stradali, il cui linguaggio è basico ma universale, per capire le funzioni base di ogni espressione visiva. È necessario lavorarci su e confrontarsi con il cliente per costruire proposte e definire un prototipo definitivo.
Per svolgere il tuo lavoro quali programmi utilizzi e quali sono le loro funzionalità?
Dipende. Personalmente il percorso che faccio è il seguente: prima di tutto sfoglio libri di settore o cerco online (ammetto che da ormai 15 anni la seconda opzione è di gran lunga la più gettonata) per sviluppare delle idee, poi ne parlo e mi confronto con i colleghi e, infine ma non per ultimo, inizio sempre il lavoro creativo con un foglio di carta e una penna a sfera. Gioco, disegno e cancello. Arrivato a questo punto perfeziono l’idea con i programmi classici del mestiere quali Illustrator, Photoshop, InDesign, After Effects, Premiere o XD, a seconda del progetto e del lavoro da svolgere. È già chiaro oggi che in un futuro breve ci saranno altri strumenti che agevoleranno di molto questo mestiere, ma non ho nessuna nostalgia del passato. La storia è così fatta: una volta per fare un’opera d’arte un’artista doveva avere anche nozioni di chimica per poter rompere, schiacciare e mischiare elementi per creare un colore bello e resistente partendo da pietre o terre. Poi sono arrivati i tubetti della Maimeri e, boom!, gli artisti hanno guadagnato un sacco di tempo che prima utilizzavano per imparare la chimica. Credo che l’innovazione sollevi dal dover perdere tempo nella specializzazione tecnica e aumenti il tempo a nostra disposizione per pensare. Secondo me è un bene, certo, dipende da cosa si pensa…
Torniamo indietro nel tempo, quali sono stati i progetti più importanti ai quali hai lavorato?
Nel particolare, a questa domanda non saprei proprio rispondere. Direi però che i progetti che preferisco sono quelli dove è possibile intervenire nella cura di tutti gli elementi della visual identity di un’azienda, sia perché è interessante per un creativo misurarsi con un’attività completa, sia perché anche il cliente ne vede i risultati.
Quale parte del tuo lavoro ti appassiona di più?
Mi piace disegnare. Qualsiasi cosa: un logo, un’illustrazione, la grafica di un libro o la grafica web. Mi piace farlo con qualsiasi cosa: una penna, un tablet, una penna grafica o un algoritmo, non mi importa. La parte più bella del lavoro è avere l’idea. Quando arriva è esaltante, anche se poi non ci cambi il mondo, ma è comunque bello crederci.